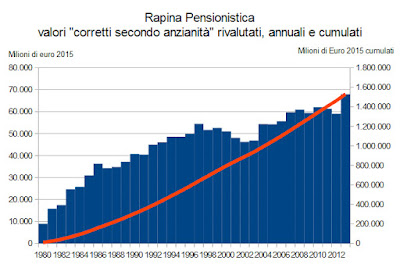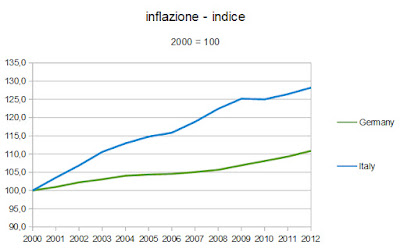"Per stare in equilibrio tra pensionati e lavoratori noi avremo bisogno di 160 mila ingressi ogni anno, solo per stare in equilibrio. Noi abbiamo oggi circa 6 milioni di immigrati che producono l’8 per cento del Pil. Che cosa vogliamo fare di questa popolazione di cui abbiamo peraltro bisogno?"
Così disse Emma Bonino qualche giorno fa in un incontro dedicato all'Europa.
E subito gli ha fatto eco Giuliano Pisapia, durente un altro evento: "Abbiamo bisogno di 200 mila migranti ogni anno".
Diciamo innanzitutto che gli ingressi di stranieri in Italia negli ultimi anni sono stati ben superiori ai 'piani' della Bonino o Pisapia (circa 250 mila). E che ben superiori a questi numeri sono gli ingressi previsti in futuro in molte stime demografiche (demoistat).
Di quanti stranieri (o migranti) abbiamo veramente bisogno?
Diciamo subito che "pianificare" l'economia, o l'occupazione, non ha mai dato buoni frutti.
I "piani" costruiti a tavolino dai politici si sono sempre infranti contro la realtà dei fatti (economici).
L'economia ha le sue ragioni, e le sue leggi, che i politici non conoscono.
L'idea di fondo della politica nostrana è molto semplice:
"Facciamo sempre meno figli: 'Importiamo' stranieri".
"Dobbiamo pagare le pensioni: 'importiamo' stranieri, che diventeranno lavoratori e pagheranno quindi le pensioni".
"La nostra economia rallenta, fatica: 'Importiamo' stranieri, che diventeranno consumatori"
Idea semplice, quanto ingenua. Perché le cose non vanno così.
E bisognerebbe parlare e ragionare soltanto di come vanno e funzionano le cose, non di come vorremmo che funzionassero.
Se 'importiamo' stranieri, questi, per poter dare un contributo, e che sia aggiuntivo, alla nostra economia, alla nostra occupazione, ai nostri consumi, al pagamento delle nostre pensioni, devono diventare lavoratori in più.
Se gli occupati stranieri vanno semplicemente a sostituire lavoratori italiani, la nostra economia, i nostri consumi, le nostre pensioni non possono riceverne alcun vantaggio.
Abbiamo già affrontato questo tema in questo articolo, vediamo ora di approfondirlo interrogando l'unico che può dirci la verità su come vanno veramente le cose: il mercato del lavoro (attraverso i dati sull'occupazione di Istat)
Purtroppo questi dati sono scomponibili secondo la cittadinanza solo a partire dal 2004, ma possiamo ben intuire (e ricostruire) gli andamenti dell'occupazione anche per anni precedenti, sapendo che la presenza di occupati stranieri prima del 1995 era del tutto marginale.
Cosa ci dicono i dati?
Che fino alla crisi, a livello generale, l'economia sembra aver assecondato i voleri dei 'pianificatori':
Dal 1995 al 2008 gli occupati sono cresciuti - anche grazie alle riforme del mercato del lavoro - e per tutte e due le componenti.
Più precisamente, dal 1995 al 2005, in 10 anni, gli occupati sono cresciuti di 2 milioni (da 20,5 milioni a 22,5 milioni): di 1 milione è stata la crescita degli occupati stranieri, di 1 milioni la crescita degli occupati italiani.
Ma già nei 3 anni successivi, fino alla crisi, l'occupazione italiana è rimasta stabile, mentre è cresciuta ancora quella straniera, di circa 800 mila.
Con la crisi è crollata l'occupazione italiana, dai 21,5 milioni del 2008 ai 20 milioni del 2013, quindi di un milione e 500 mila. Gli ultimi due anni hanno visto una ripresa dell'occupazione italiana che ha portato il crollo dall'inizio della crisi a circa un milione in totale. Nel frattempo l'occupazione straniera invece è cresciuta, di circa 700 mila.
Negli ultimi dieci anni di 'crisi' quindi vi è stata una sostituzione di occupazione italiana con occupazione straniera. E l'occupazione totale è ancora inferiore a quella precedente la crisi.
Uso senza timore il termine sostituzione, perché, in campo economico, è una parola quanto mai innocua.
Molti immaginano la sostituzione come quella dell'operaio italiano che viene licenziato per assumere l'operaio straniero. Ovviamente non è questa la sostituzione di cui parliamo, e che è avvenuta in Italia.
In economia esistono beni sostituti, che soddisfano un "medesimo bisogno del consumatore", e sono quindi tra loro 'concorrenti'; ma a ben vedere, tutti i beni sono tra loro sostituti, in senso più ampio, e quindi tra loro concorrenti, perché tutti cercano di contendersi il denaro del consumatore:
se decido di fare una vacanza in montagna, non farò una vacanza al mare, e le due spese sono quindi sostitute, ma facendo la vacanza in montagna dovrò magari anche rinunciare al nuovo televisore che volevo comprare, o allo scooter, o a quei gioielli che volevo regalare alla fidanzata, etc.
Ugualmente, per il mercato del lavoro:
Se suddividiamo gli occupati totali secondo la cittadinanza, quindi tra italiani e stranieri, l'aumento degli occupati stranieri a fronte della riduzione degli occupati italiani non può che chiamarsi sostituzione.
Ed è una sostituzione sia diretta che indiretta:
In via diretta perché l'imprenditore che sceglie di assumere un operaio straniero, non sceglie di assumere un operaio italiano.
In via indiretta, perché come nell'esempio precedente, tutti i beni offerti sul mercato sono tra loro concorrenti, e questo vale anche per il lavoro, questo vale anche tra lavori molto differenti:
se un anziano trova conveniente assumere una badante, straniera, avrà indirizzato il consumo, quindi i suoi soldi, per quella spesa, rinunciando ad altri servizi, magari professionali, legali, culturali.
Avviene così che l'aumento delle badanti possa togliere lavoro persino ad architetti, avvocati, ingegneri, etc.
"Ma sarà così solo in una economia statica o in declino", si obietterà.
Che è appunto quella che abbiamo in Italia da quasi dieci anni a questa parte.
Ma vediamo di scomporre il grafico visto precedente in maniera più efficace, per territori e per sesso, per evidenziare qualche altra particolarità del mercato del lavoro.
Questi due grafici ci dicono che il crollo del lavoro italiano non ha riguardato in misura uguale uomini e donne: le donne hanno mantenuto quasi lo stesso livello pre-crisi, dopo essere aumentate per molto tempo (crescita fin dall'inizio della serie). In qualsiasi caso, quindi, questa crescita si è interrotta.
Il crollo ha riguardato più che altro l'occupazione maschile. In questo caso, tracciando una curva immaginaria che completi anche i dati mancanti dal 1995 al 2004, si può vedere facilmente che, addirittura, il numero di occupati, per gli uomini, è probabilmente calato della metà degli anni '90 fino agli anni 2000, è rimasto costante per qualche anno, ed è crollato con la crisi, di un milione e mezzo prima, un milione in totale. Appunto le variazioni già evidenziate in precedenza.
Quanto agli stranieri, la crescita è stata abbastanza simile per uomini e donne: + 900 mila per gli uomini, +700 mila le donne, dal 2004 ad oggi.
Vediamo altri dettagli per territorio:
Nord-Ovest:
Il Nord-Ovest è l'area dove la sostituzione italiani-stranieri è stata più evidente,
Gli occupati italiani uomini sono verosimilmente calati in tutti gli anni '90.
Sono rimasti stabili fino alla crisi per poi crollare, di 300 mila unità.
Nel frattempo gli occupati stranieri sono cresciuti continuamente, fino a 500 mila unità, + 200 mila circa durante la crisi.
Meglio per le donne: anche qui l'occupazione delle italiane è cresciuta durante gli anni '90, è rimasta stabile per tutti gli anni 2000, anche durante la crisi. Nel frattempo quella stranieri arrivava a circa 400 mila.
Qui sotto vediamo la situazione per le altre zone:
Nord-est, con considerazioni simili a quelle fatte per il Nord-Ovest
Centro:
Mezzogiorno:
Quindi, stando agli andamenti del mercato del lavoro, possiamo vedere che l'occupazione straniera, negli ultimi dieci anni, ha semplicemente sostituito quella italiana.
Qualunque ulteriore apporto di stranieri, visti questi andamenti, se l'economia italiana non cambia "passo", non apporterebbe alcun contributo aggiuntivo. E potrebbe invece avere altre conseguenze negative.
Ma questi dati non bastano.
Qualcosa di ancora più eloquente ci viene dalle variazioni degli occupati, stranieri.
O dalla percentuale di nuovi occupati stranieri calcolata sullo stock di potenziali occupabili (disoccupati + inattivi):
Come si può vedere, sebbene gli occupati siano cresciuti continuamente negli ultimi anni, sostituendo lavoro italiano, è anche vero che questa crescita è rallentata, ed è arrivata ultimamente a valori minimi.
Se fino ad ora, quindi, l'occupazione straniera è cresciuta, per motivi che ora non analizzeremo, è probabile che questi motivi si siano quasi esauriti, o, detto in altro modo, anche il mercato del lavoro straniero si è quasi saturato.
Dove andranno a finire quindi i 160 mila o 200 mila stranieri che molti vorrebbero continuare ad "importare"? Sicuramente ad aumentare il numero di disoccupati o inattivi stranieri, con evidenti costi economici e sociali.
Il problema quindi non è stabilire di quanti stranieri ha bisogno la nostra economia, ma come fare per creare più occupazione, per gli italiani e per gli stranieri.
Ovvero, come uscire da questa crisi eterna.